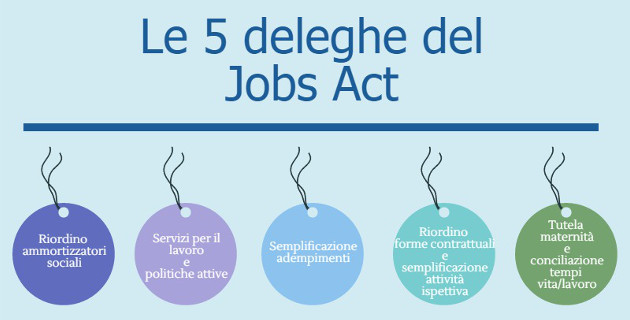Un milione… il suocero di Bellavista, interpretato da Aldo Tarantino in quel film memorabile dedicato alla grandezza della napoletanità si svegliava dal suo torpore solo quando qualcuno intorno a lui pronunciava quel numero. “Un milione…” poi ritornava in trance.
Nel 1917 la penna di Sergio Tofano disegnava, per il Corriere dei Piccoli “il signor Buonaventura” anche lui alla ricerca del “Milione”. Un milione. Un numero indiscutibile utilizzato per certificare un successo.
In un passato recente era riuscito solo a Berlusconi evocare, su di un altro versante, quello del lavoro, lo stesso valore simbolico di quel numero: un milione di posti di lavoro. Quel numero poi è caduto nel dimenticatoio per qualche anno, tra mille polemiche.
Un numero che comunque evoca un obiettivo da raggiungere, un risultato indiscutibile, una sorta di certificazione in ogni campo per chiunque. Difficile non riutilizzarlo.
Maria Elena Boschi recentemente lo ha rilanciato su Twitter: “Quasi 1 milione di posti di lavoro grazie al #JobsAct e dal primo giorno del Governo dei #MilleGiorni. I numeri parlano.” E, com’era prevedibile si è scatenata la polemica.
Cosa c’è dietro questo numero, (raggiunto) di occupati in più, di così negativo da scatenare, prima i detrattori di Berlusconi ed oggi, quelli di Renzi? E, venendo ai giorni nostri, è possibile (o è utile) stabilire un legame di causa effetto con il Jobs Act? E, soprattutto, il successo o l’insuccesso del Jobs Act, può essere valutato su di un arco di tempo così breve e su un dato qualitativo così eterogeneo?
Difficile rispondere senza essere immediatamente arruolati da una parte o dall’altra. Che lo si voglia ammettere o meno, una cosa però sembra certa: il Jobs Act pur accolto bene dalle associazioni datoriali non lo è stato altrettanto dalle imprese.
I dati parlano chiaro. Il ricorso alle assunzioni a tempo determinato resta prevalente. Era scontato ma in pochi lo avevano messo in conto. Vediamo perché. Innanzitutto la querelle sull’articolo 18. Il mondo delle imprese lo ha sempre considerato un ostacolo da rimuovere però pochi imprenditori erano disposti ad accettare, su questo tema, una lunga battaglia di principio.
Lo si era già capito ai tempi del tentativo (fallito) del Governo Berlusconi. La crisi e le ristrutturazioni avevano trasformato questo simbolo del novecento in una tigre di carta.
Quindi era evidente che la sua rimozione, pur ritenuta utile, non avrebbe sortito, di per sé, l’effetto sperato dal Governo e da quei giuslavoristi sempre più propensi a individuare ostacoli nelle regole preesistenti e a legiferare in tal senso che non a prestare attenzione ai cambiamenti del contesto socio economico indotto dalla globalizzazione.
Difenderlo o rimuoverlo era comunque una battaglia di retroguardia. E così è stato. Nessuno ne ha fatto un dramma né si è sentito rassicurato. Lo stesso aumento dimensionale sopra i 15 dipendenti di alcune imprese ha ben altre cause. Solo chi non è mai stato in azienda può pensare che nel 2017 un imprenditore possa rinunciare concretamente ad espandersi per l’art. 18.
Così come lo è la convinzione che un imprenditore scelga, a cuor leggero, un contratto a tempo indeterminato rispetto ad uno a tempo determinato in questa situazione economica. Quel mondo non c’è più. La prevalenza dei contratti a tempo determinato è strutturale. Ma non c’è niente di negativo. Lo dico soprattutto per coloro che pensano che bisognerebbe disincentivarlo rendendolo più costoso.
È il lavoro che dovrebbe poter essere a tempo indeterminato. Non il singolo posto di lavoro. E, per ottenere questo risultato, le risorse andrebbero impiegate per costruire le condizioni più adatte a questo cambiamento. Innanzitutto culturale.
Quindi occorrerebbe investire ancora più pesantemente su alternanza, apprendistato, formazione permanente e politiche attive. Non solo su sgravi contributivi che rischiano di lasciare il tempo che trovano una volta che esauriscono il loro effetto.
Non c’è nessuna ragione che possa spingere le imprese ad assumere scegliendo il tempo indeterminato come prevalente se non in funzione del proprio modello di business.
Basterebbe osservare le relazioni e le problematiche delle PMI, la gestione complessa delle commesse, il loro ruolo in rapporto alle altre imprese nazionali nelle filiere, la centralità della questione fiscale, i problemi di legalità del contesto, la burocrazia con cui devono misurarsi, i costi degli investimenti necessari a competere, per comprendere la necessità di ripensare anche il fattore lavoro.
Emanuele Massagli ci ricorderebbe la differenza tra tutelare il lavoro NELLA flessibilità dal tutelare il lavoro DALLA flessibilità. Con Marco Biagi si era scelta la prima strada, purtroppo non completandola. Poi si è preferito percorrerne un’altra.
Qui sta il punto. Se l’impostazione prevalente continuerà ad essere sempre quella del lavoro del novecento con al centro la cultura della grande impresa manifatturiera continueremo a doverci misurare sul costo del lavoro, sulla produttività e sulla flessibilità seguendo uno schema superato che vede il problema nello smantellamento o nella difesa delle tutele o delle conquiste del passato.
Se, al contrario, capiremo che la dimensione del nostro tessuto produttivo, industriale e terziario, va da tutt’altra parte forse non ci stupiremmo di fronte a dati che parlano da soli. E soprattutto non correremmo il rischio di peggiorare ulteriormente la situazione penalizzando il lavoro regolare comunque creato.
Il Jobs Act ha tentato, senza riuscirci, di mettere insieme il passato con il futuro. Così i suoi sostenitori si sono trovati contro i passatisti senza avere al proprio fianco i fautori del cambiamento vero. Per questo ci si rincorre sui numeri continuando, però, ad utilizzare calcolatrici differenti.
E così il tempo determinato vale meno, il lavoro nero non compare nelle statistiche, l’alternanza non funziona, i voucher sono sbagliati, i giovani continuano a faticare a trovare lavoro passando attraverso interminabili stage e non attraverso l’apprendistato e così via. E tutto questo impedisce di vedere anche la positività di alcuni provvedimenti.
Personalmente credo che l’errore stia proprio nel pensare che sia sufficiente continuare a “drogare” il sistema esistente per paura di cambiarlo. Una forza riformista che ambisce a traghettare il Paese verso il suo futuro non può né sventolare il tramonto dell’articolo 18 come un successo né perdersi dietro un pallottoliere. Altri sono più bravi, su questo terreno, perché hanno una strategia precisa di interdizione e di denuncia.
Mettere al centro il lavoro significa porsi il problema del lavoro di oggi e di domani. Della sua quantità ma anche della sua qualità. Per questo, più che continuare a legiferare, occorrerebbe predisporsi ad ascoltare in modo nuovo il mondo del lavoro a 360 gradi, le sue priorità, le sue aspettative e i suoi problemi.